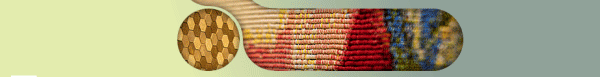Reciprocità, comunicazione, tracciamento, rigore. Sono queste le parole chiave con cui si è concluso il convegno che ieri pomeriggio si è svolto al Museo del Tessuto di Prato sul tema della nuova regolamentazione francese sull’Ultra Fast Fashion e sui suoi impatti sulla filiera italiana e pratese. Reciprocità come condizione essenziale per una corretta concorrenza. Comunicazione del valore dei capi in modo che sia chiara la differenza tra pantaloni da 200 euro e altri da 10 euro. Tracciamento corretto della qualità del materiale e del processo produttivo del capo. Rigore nei confronti di chi non rispetta le regole etiche, anche se si tratta di grandi nomi.
Temi importante, già all’attenzione di Confindustria Moda, come ha sottolineato Francesco Marini, presidente della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord, in apertura del convegno: “Tra gli importanti temi portati all’attenzione del Senato pochi giorni fa – ha commentato – ci sono anche l’approvazione del decreto attuativo EPR tessile, la tutela della competitività europea del Tessile/Moda, la legge di contrasto all’ultra fast fashion, il Tavolo della Legalità di Filiera e il Piano Nazionale di Comunicazione sul Made in Italy. C’è grande attenzione alle necessità della filiera da parte di Confindustria, ma c’è anche grande impegno da parte delle imprese per allinearsi alle nuove normative sulla sostenibilità. Proprio alla luce di questo impegno è essenziale che sia assicurata la reciprocità, altrimenti ogni sforzo è vano”.
Dopo i saluti di Giuseppe Moretti, presidente dell’associazione Ex Allievi ITS Buzzi e vicepresidente della Fondazione Museo del Tessuto, si è entrati nel vivo della questione con un esame della legge francese verso la quale nutre alcuni dubbi Silvia Gambi, founder di Solo Moda Sostenibile: “La legge lascia alcune perplessità. In primis il fatto che non definisce l’Ultra-Fast Fashion: dobbiamo usare il parametro dei prezzi? Oppure del numero di capi prodotti? E’ una legge che guarda espressamente a Shein? Inutile dire che il problema dell’Ultra-Fast Fashion può comunque presentarsi anche con un altro nome. Guardiamo alle imprese pratesi: producono in maniera diversa quando vendono a Inditex (certamente marchio del Fast Fashion) rispetto a quando vendono ai brand del lusso? E perché se entriamo in uno store Uniqlo non pensiamo al fast fashion, per quanto i suoi numeri lo facciano entrare in quest’area di prodotto? Evidentemente lo storytelling, la pubblicazione di bilanci di sostenibilità danno i loro frutti nella percezione dei consumatori. Ci sono molti punti da chiarire, ma certamente quello che cambierà la situazione – ha commentato – non sarà una legge, ma il consumatore, quando cambierà il suo approccio agli acquisti e alla valutazione della qualità del capo”. Dubbi sulle pecche della legge francese sono state avanzate anche da Aldo Godi, co-fondatore dello Studio Legale TML, che sottolinea come molto decisioni siano state rimandate alla decretazione successiva da parte del Governo. “La stessa Commessione Europea – commenta – ha censurato in vari punti questa legge. Il problema grande è che i tempi della legislazione, tanto più quella europea, sono lentissimi, il problema del fast fashion, invece, evolve con ritmo rapidissimo e rischiamo di non essere pronti”.
Un relatore che ben conosce la Francia è Massimo Bruni, titolare di Moma Concept, che insinua il dubbio che la motivazione della Francia nell’emanare questa norma sia sostanzialmente quella di affossare il Made in Italy a favore del Made in Europe e alla lunga del Made in France. E’ invece Roberto Rosati, titolare del Lanificio Fortex, che sottolinea come l’Ultra-Fast Fashion sia un problema non solo per le imprese italiane, ma anche per l’ambiente, dato che il 90% dei materiali usati per questo tipo di capi non è riciclabile. “Disciplinare i flussi di abiti verso l’Italia ed educare i consumatori ad acquisti più etici sarà determinante – ha commentato – dato che se non troviamo soluzioni entro il 2029 la filiera del riciclo andrà in crisi e non basteranno i processi innovativi che imprese come la mia hanno ideato per riciclare anche quello che riciclabile non è”.
Le conclusioni emerse sono che è indubbiamente malato il comparto della commercializzazione a causa del divario esagerato tra il costo del prodotto e il suo prezzo finale; che è necessario un controllo vero della filiera, fatto da enti certificatori europei e italiani, dato che quelli cinesi non rispettano gli stessi standard; che solo scelte politiche forti possono portare a norme corrette ed efficaci.